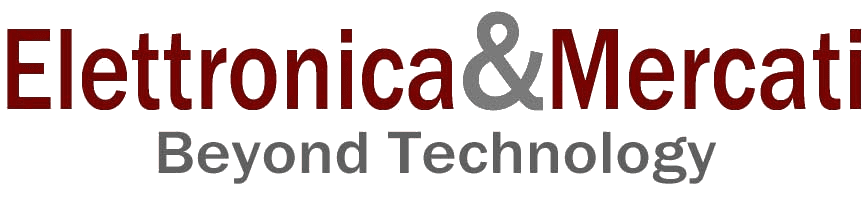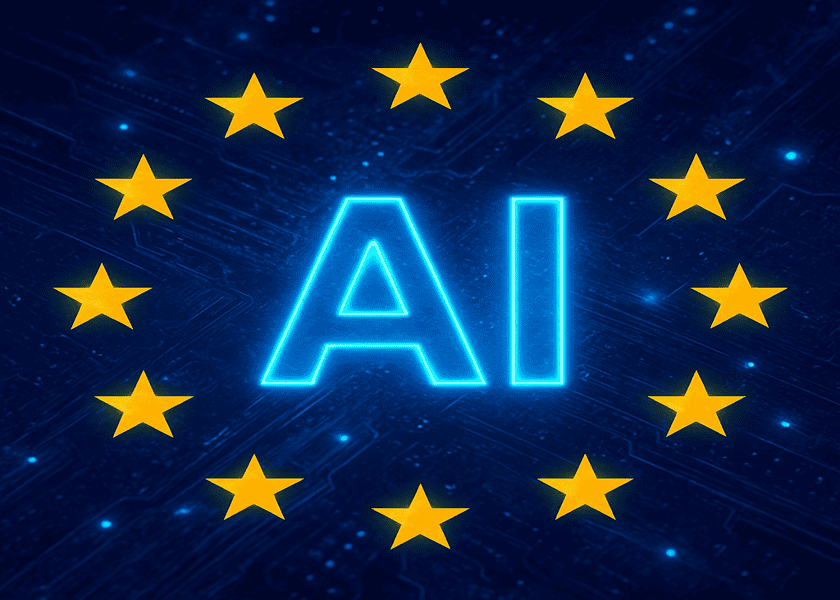
Con il lancio della strategia Apply AI e del piano AI in Science, l’Unione Europea intende moltiplicare l’adozione dell’intelligenza artificiale nei settori chiave, ridurre la dipendenza tecnologica da Stati Uniti e Cina e rafforzare la sovranità digitale. Tra annunci ambiziosi, sfide normative e ostacoli reali, emerge il paradosso di un’Europa che vuole essere avanguardia nella regolazione dell’IA ma fatica ad accelerare sull’innovazione.
Con il suo recente lancio, la strategia Apply AI vuole essere il volano operativo dell’Europa per l’intelligenza artificiale: più che una visione astratta, un piano concreto per spingere l’adozione dell’IA nei principali settori industriali, nei servizi pubblici e nella ricerca scientifica.
L’idea è chiara: non bastano normative e principi etici (che pure l’Europa ha sviluppato con l’approccio “eccellenza e fiducia” – serve fare in modo che aziende, amministrazioni e laboratori abbiano incentivi, strumenti e infrastrutture per utilizzare concretamente l’IA.
In parallelo, nasce la strategia AI in Science, che mira a trasformare la ricerca europea mediante l’IA, con la creazione di una struttura virtuale chiamata RAISE (Resource for AI Science in Europe).
Per coordinare queste iniziative è prevista la costituzione dell’Apply AI Alliance, forum che riunirà industria, pubblico, accademia e società civile, e di un Osservatorio AI per monitorare gli sviluppi tecnologici e valutare impatti settoriali.
Ambizioni e strumenti: dove vuole spingere Bruxelles
Uno dei pilastri della strategia è rafforzare la sovranità tecnologica europea, riducendo la dipendenza da tecnologie estere — in particolare quelle statunitensi e cinesi — in infrastrutture, algoritmi, chip e servizi cloud.
A tal fine, la Commissione ha già annunciato l’allocazione di circa 1 miliardo di euro da fondi esistenti per accelerare l’adozione dell’IA nei settori strategici: sanità, industria manifatturiera, energia, mobilità, difesa, biotecnologie.
Per favorire la sperimentazione, la strategia prevede il potenziamento delle infrastrutture esistenti: AI Factories, AI Gigafactories, spazi di test e sperimentazione, sandbox regolamentari, nonché punti di accesso regionali (European Digital Innovation Hubs) trasformati in “experience centres”.
Per la ricerca scientifica, RAISE dovrà supportare gli scienziati nell’accesso a infrastrutture, modelli e dataset di alta qualità, con finanziamenti dedicati (circa 600 milioni da Horizon Europe) e un piano per raddoppiare gli investimenti annui in IA.
Un elemento chiave sarà anche la semplificazione normativa per favorire le imprese, in particolare le PMI, nel percorso di adozione dell’IA. La strategia cerca di allineare i vincoli dell’AI Act con strumenti operativi.
Le critiche: grandi ambizioni, impatto incerto
Non mancano le voci critiche: alcune analisi segnalano che molti degli strumenti previsti dalla strategia non sono nuovi, ma riorganizzazioni o etichette per iniziative già esistenti. Insomma, grandi ambizioni ma con scarsa capacità di cambiamento reale.
Tra le perplessità, la difficoltà per le piccole realtà di assorbire i requisiti normativi, la mancanza di capitali di scala e le infrastrutture cloud e di calcolo in Europa, che sono spesso meno competitive rispetto agli Stati Uniti o alla Cina.
C’è anche chi avverte che la strategia rischia di essere troppo focalizzata sui grandi “verticali” a scapito di settori sociali meno profittevoli, come i servizi sociali, per i quali si chiede maggiore inclusione nel piano.
Infine, l’implementazione dell’AI Act, entrato in vigore il 1° agosto 2024 (con molte disposizioni attuative in corso), mette i paesi UE davanti alla sfida di bilanciare un regime regolatorio avanzato con la necessità di non soffocare l’innovazione.
In che misura l’Europa può reggere la corsa globale all’IA
L’Unione parte da una posizione complessa: molte aziende europee non usano ancora l’IA (solo il 13,5 % delle imprese UE ne fa uso). Mancano modelli di business su larga scala, infrastrutture sovranazionali di calcolo e interoperabilità entro il continente.
Altri ostacoli sono i costi energetici elevati, una frammentazione normativa tra gli Stati membri, e il divario in capitale di rischio rispetto agli ecosistemi statunitensi e asiatici.
Tuttavia, l’Europa ha punti di forza che può valorizzare: una forte presenza nel manifatturiero avanzato, competenze scientifiche consolidate, una sensibilità normativa che può tradursi in vantaggio competitivo (IA affidabile, trasparenza, etica) e una rete di centri di innovazione già attivi.
Se Bruxelles riuscirà a tradurre le linee guida della strategia in esecuzione concreta, a mobilitare capitale su scala e a integrare gli sforzi nazionali, l’Europa potrebbe emergere non come inseguitrice dell’IA, ma come laboratorio internazionale di applicazione responsabile e industriale.